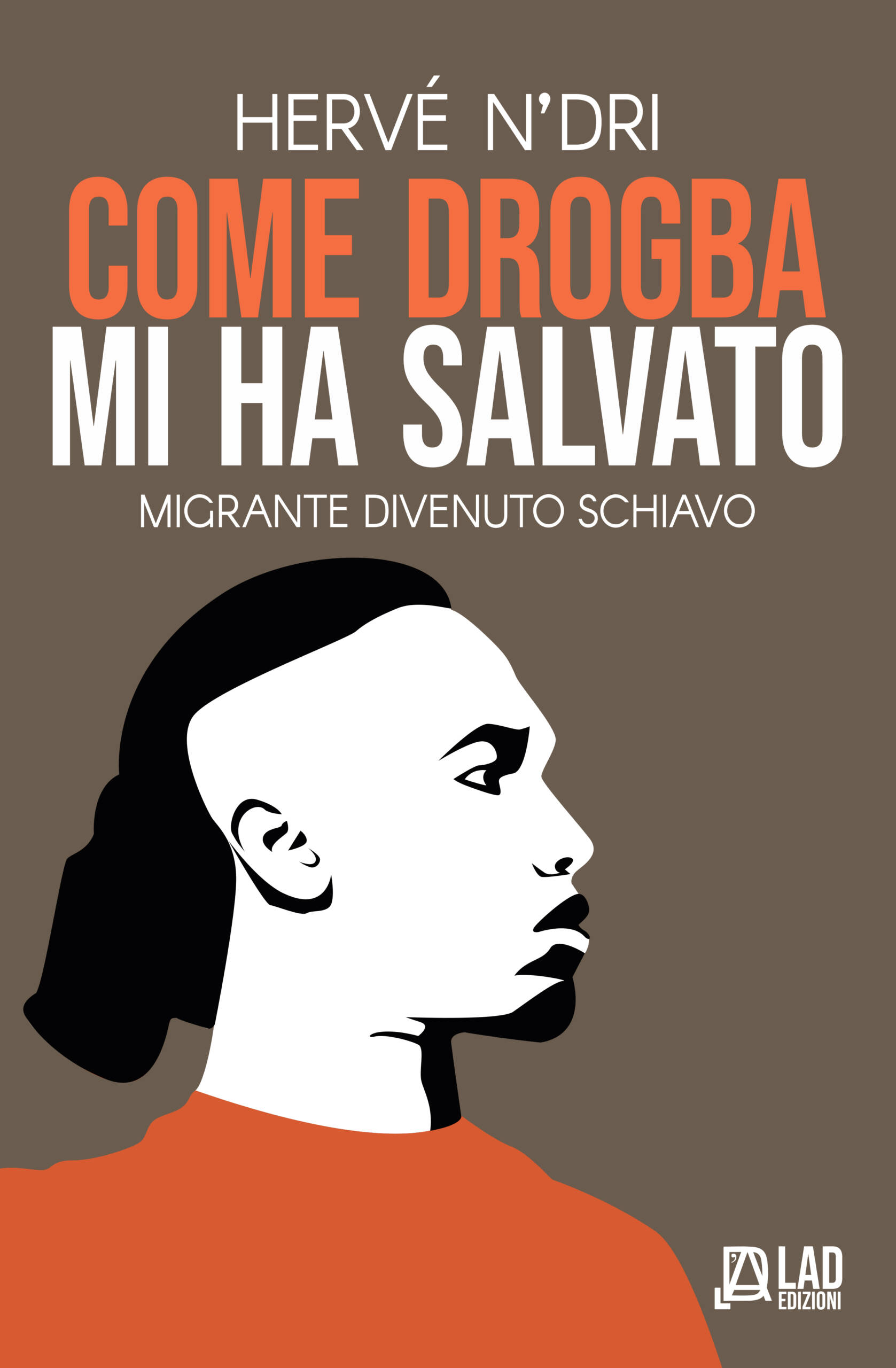UE, un bilancio comunitario all’insegna dell’economia di guerra
di Emiliano Gentili e Federico Giusti
Un Bilancio è un documento di programmazione economica con una durata in anni predefinita. Descrive come verrà utilizzato il gettito in entrata nelle casse statali, frazionandolo tra le varie priorità della società – dai servizi essenziali alle attività economiche, a infrastrutture, investimenti, assistenza e così via.
Nel Bilancio Europeo non viene meno l’intento programmatico e regolatore, tuttavia ci sono anche delle differenze importanti rispetto ai consueti bilanci nazionali: dal momento che l’agire delle istituzioni europee è sottoposto per forza di cose a un certo grado di intermediazione politica, per via dell’esistenza degli Stati nazionali, nel Bilancio ci si mantiene sostanzialmente nell’ambito degli interventi “stimolativi”, atti cioè a provocare indirettamente un effetto desiderato – ad esempio sugli investimenti privati o sulle legislazioni degli Stati membri. Esito di quest’impostazione è che sfogliando il Bilancio comunitario ci si trova proiettati in una dimensione per certi versi molto più politica che economica: «Il nuovo bilancio dell'Ue sarà un bilancio basato sulle politiche»[1].
Cosa intende fare, dunque, l’Unione Europea? Sicuramente c’è un tentativo di uniformare i mercati e le legislazioni dei Paesi membri, al fine di costruire un mercato unico interno europeo e di attrarre maggiori investimenti; la strada scelta per raggiungere questo obiettivo pende in direzione dell’allentamento dei vincoli normativi – sia a livello di economia reale che di finanza –, almeno in questa fase. Altro aspetto saliente è la subordinazione alle esigenze del settore militare di tutte le politiche per la competitività, per l’avanzamento tecnologico e per la costruzione di nuove infrastrutture di trasporto ed energetiche.
Nello scrivere questo articolo, perciò, la nostra preoccupazione era di mettere sufficientemente in evidenza questi due aspetti, che a nostro avviso sono i principali. Allo stesso tempo verrebbe da riflettere su come l’Ue stabilisca direttrici importanti per il futuro dei popoli ad essa soggetti senza che alcuno di questi venga interpellato: sono lontani i tempi dei Referendum sulla Costituzione europea. Su questo, però, potremmo tornare in un prossimo intervento. Del resto ogni Bilancio è un argomento complesso, che non per forza è utile sviscerare punto per punto per poi, magari, rinunciare alla visione d’insieme.
- Finanziamento del Bilancio e contributi nazionali
Nel 2028 partirà il rimborso dei fondi Ngeu (168 miliardi, comprensivi dei fondi del Pnrr), in coincidenza con l’inizio della programmazione di Bilancio. Ciò comporterà oneri aggiuntivi per le casse degli Stati, ragion per cui la Commissione ha dichiarato di mantenere sostanzialmente invariati i contributi nazionali ordinari all’Ue. Ciononostante la manovra vale ben 1.980 miliardi di Euro, cifra a cui corrisponde l’1,26% del Reddito Nazionale Lordo dell’Ue-27. Quest’ultimo parametro è quello che viene usato per definire il massimale – cioè il limite massimo – dei pagamenti che possono essere richiesti dall’Ue. Ebbene, tale soglia viene elevata all’ 1,75%[2], il che vuol dire che potranno essere chiesti ai Paesi degli ulteriori contributi. Inoltre, in caso di inflazione superiore al 3% il cosiddetto “deflatore” (l’indice che misura la variazione media dei prezzi di beni e servizi), a cui è ancorata la predetta soglia, verrebbe aumentato e, con ciò, i contributi nazionali verrebbero in automatico fortemente adeguati all’inflazione, determinando spese extra. La stessa cosa avverrebbe, all’opposto, in una situazione di inflazione al di sotto dell’1%[3].
Ciò detto, per finanziare il proprio Bilancio la Commissione possiede altre risorse oltre ai contributi delle singole nazioni. Queste sono essenzialmente di tipo commerciale (dazi doganali, aliquota sull’Iva), ma comprendono anche alcuni altri tipi di imposte, come quella sui rifiuti di imballaggi di plastica non riciclati – della quale, per inciso, si propone l’aumento. Per il futuro si prevede l’introduzione di nuovi prelievi sulle transazioni commerciali e le attività economico-produttive. Essi saranno:
- un’aliquota del 30% sull’imposta applicata al sistema dello scambio di quote di emissione di CO2. I proventi derivati da queste transazioni, d’ora in poi, verranno riscossi solo al 70% dagli Stati nazionali. È poca cosa, si dirà: per l’Italia i proventi totali dal 2012 al 2024 ammontano a “soli” 15,6 miliardi, ossia a poco più di un miliardo all’anno di media. Per quanto siamo a conoscenza, però, sembra che ai più sia sfuggito un dettaglio. Dal 2027, infatti, «un sistema di pricing del carbonio sarà applicato anche ai fornitori di carburanti e combustibili fossili per i settori dei trasporti, degli edifici e delle imprese medio piccole con il sistema dell’EU ETS 2. I costi della CO2 verranno, di fatto, trasferiti dai fornitori di energia da fonti fossili ai consumatori finali. Il cosiddetto ‘segnale’ di prezzo della CO2 dovrebbe, quindi, portare i consumatori a scelte di efficienza energetica ed elettrificazione dei consumi finali, adottando soluzioni a zero-basse emissioni»[4]. Tutto ciò, è facile dirlo, si tradurrà in un aumento dei ricavi sia per gli Stati che per l’Ue, pagato dall’aumento delle bollette delle famiglie. Il Bilancio, però, si guarda bene dal parlarne;
- una tassa agli Stati sui rifiuti elettronici non raccolti. «L'applicazione di un contributo nazionale basato sui rifiuti non raccolti comunicati dagli Stati membri incentiverà la riduzione dei rifiuti e incoraggerà la raccolta differenziata»;
- un nuovo contributo dalle imprese, con esenzione per quelle di piccole e medie dimensioni;
- una nuova accisa sul tabacco;
- «nuove tariffe [non meglio specificate] relative alle politiche dell’Unione»[5].
Dunque, in realtà i contributi nazionali aumentano, per quanto non lo si voglia dire.
- Modalità di finanziamento, governance, razionalizzazione amministrativa
Spendiamo due parole sulle modalità di finanziamento. A livello di Bilancio vi sarà una maggiore flessibilità data dalla possibilità che i fondi vengano riassegnati in base a mutate esigenze e, soprattutto, dalla costituzione di tre livelli di riserve finanziarie anti-crisi, fino a quello definito “Meccanismo di crisi”[6]. Il riferimento non è alle sole crisi economiche ma anche a guerre, epidemie, catastrofi ambientali e via dicendo.
Il meccanismo utilizzato per reperire i fondi Pnrr prevedeva che l’Ue prendesse capitali in prestito sul mercato al posto dei singoli Paesi – visto che poteva accedere a tassi d’interesse vantaggiosi, in quanto istituzione finanziariamente più solida –, per poi “girarglieli”. È appunto al mercato che dovremo rimborsare quelle risorse, con gli interessi. Comunque sia, nel nuovo Bilancio si prevede che tale meccanismo venga “istituzionalizzato” e che possa funzionare per qualunque Paese quando questi ne abbia l’esigenza, purché reale e fortemente motivata.
Altro aspetto importante è la governance dei finanziamenti. L’erogazione delle tranche, così come avvenuto col Pnrr, avverrà sulla base della verifica dei risultati conseguiti. Non si tratterà più soltanto di approvare progetti e mandare avanti i cantieri – cosa nella quale comunque i nostri governi non si sono dimostrati di certo eccellenti –, quanto più in generale di «garantire che gli investimenti producano i risultati auspicati», rendendo possibile subordinare esplicitamente i prestiti di maggiore entità – e quindi quelli con obiettivi più generali – a indicatori economici relativamente indipendenti, quali la produttività, la capacità di attrarre investimenti in un determinato settore per poter aprire certe attività produttive, ecc. Quel che prima, col Pnrr, veniva ottenuto abbinando Investimenti a Riforme, che dovevano garantirne l’attuazione sul piano politico, adesso lo si vuole ottenere congiuntamente. Ciò che non cambia è l’intenzione di ridurre «notevolmente gli obblighi di rendicontazione per i destinatari dei fondi, concentrando le verifiche e i controlli sui risultati tangibili dei progetti anziché sui costi»[7], per la gioia della criminalità organizzata nostrana.
A questo punto della trattazione giova mettere il lettore a conoscenza del fatto che gli aspetti politici del Documento citato (che tecnicamente è una Comunicazione della Commissione Europea) non hanno valore operativo, né alcun valore giuridico vincolante. Tuttavia possono essere affrontati quasi come se l’avessero: si tratta del parere di un organo di un legislatore (l’Unione Europea), avente autorità limitata, che decide per proprio conto. Ed è per questo che le Comunicazioni della Commissione sono importanti: esprimono un’aspettativa altamente probabile, spesso quasi certa, sulla legislazione e gli orientamenti futuri.
Senza capire questo non si comprenderebbe come mai, ad esempio, la Commissione possa presentare come fatto certo che le garanzie di Bilancio verranno concesse a destra e manca, come «parte integrante del pacchetto di strumenti di finanziamento, a sostegno di prodotti quali il debito di rischio, i prestiti e gli investimenti in capitale proprio», per svolgere «un ruolo più incisivo nella riduzione dei rischi per gli investimenti privati e nello svincolo di finanziamenti provenienti da investitori privati»[8].
Come sempre nei momenti di difficoltà, i governi provano a mettere in atto una sorta di razionalizzazione dell’amministrazione, al fine di risparmiare e/o attrarre capitali. È quello che farà anche l’Ue, semplificando le condizioni per l’accesso ai finanziamenti, riducendo i programmi, applicando un sistema unico di monitoraggio della spesa, ecc.
- Nuovi strumenti economici attuativi
Uno strumento fondamentale del nuovo Bilancio saranno i piani di partenariato stipulati con i Paesi o le Regioni, che rafforzeranno i precedenti investimenti per le politiche comuni europee (ad esempio in fatto di agricoltura). L’obiettivo è andare a uniformare gradatamente il mercato interno almeno in alcuni settori, definiti «prioritari». Attualmente le divisioni nazionali creano una miriade di legislazioni e sistemi di tassazione differenti e, inoltre, provocano una riduzione della scala delle economie e maggiori costi per le imprese (cosiddetti “costi di conformità”), vale a dire meno investimenti. A questi piani di partenariato andranno 865 miliardi.
Il criterio per l’adempimento ai compiti di partenariato sarà, ancora una volta, quello del conseguimento del risultato. Tuttavia, rispetto al Pnrr vi sarà maggiore libertà sulle modalità con cui raggiungere gli obiettivi[9]. Il problema è però un altro: migrazione, gestione delle frontiere e sicurezza saranno sempre più vincolate all’autorità europea, in quanto d’ora in poi i progetti comuni in quei settori rientreranno all’interno dei piani di partenariato, per cui i relativi investimenti saranno sbloccati solo a seguito delle riforme concordate: «Il legame tra riforme e investimenti fornirà agli Stati membri maggiori incentivi per attuare il patto sulla migrazione e l'asilo e la strategia di sicurezza interna dell'Ue»[10].
Altro strumento importantissimo sarà il Fondo Europeo per la Competitività, basato su risorse di Bilancio (ossia soldi pubblici). Preconizzato nel Rapporto Draghi, questo Fondo «sosterrà settori critici per la competitività dell'UE: transizione pulita e decarbonizzazione; leadership digitale; resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio; e salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia». Ciò al fine di fungere da «catalizzatore degli investimenti privati. Il Fondo europeo per la competitività offrirà un insieme completo di strumenti di finanziamento per attirare investimenti privati»[11], diversificando l’offerta. Secondariamente, il Fondo finanzierà anche i partenariati pubblico-privato, come gli Ipcei[12].
Altri strumenti sono, ad esempio, Orizzonte Europa (finanziamento della ricerca) e Europa Globale, che cura la proiezione “geopolitica” dell’Ue. Su 200 miliardi di dotazione di Europa Globale, «circa 25 miliardi di EUR dovrebbero essere destinati agli aiuti umanitari»; il resto si tradurrà prevalentemente in investimenti economici.
- Proiezione globale dell’Ue e Difesa
Questo non è un normale Bilancio: è un Bilancio da economia di guerra. I provvedimenti contenuti nel Documento che abbiano a che fare col settore militare sono innumerevoli e vi fanno riferimento sia le politiche per la competitività che quelle per i collegamenti stradali, ferroviari ed energetici tra Paesi membri, che verranno progettati tenendo presente le necessità militari: «La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha evidenziato l'importanza di investire nella mobilità militare (…). Investimenti saranno destinati a favorire il trasporto di truppe e attrezzature per ferrovia, strada, via aerea, porti marittimi, vie navigabili interne e terminali multimodali»[13]; saranno finanziati «progetti di trasporto a duplice uso civile-militare per consentire una mobilità militare senza soluzione di continuità in tutta l'Ue»[14].
Verrà fatto ampio uso di appalti militari trans-nazionali e sarà razionalizzata la produzione di armamenti. Se Draghi, infatti, nel proprio Rapporto aveva ancora a lamentarsi del fatto che «Attualmente in Europa vengono prodotti cinque tipi diversi di obici, mentre gli Stati Uniti ne producono solo uno. Ci sono dodici tipi di carri armati europei, mentre negli Stati Uniti ce n'è solo uno»[15], negli ultimi anni gli sforzi fatti per uniformare la produzione bellica iniziano a farsi evidenti[16].
Nel Bilancio europeo si fa esplicito riferimento alla possibilità di andare in deroga ai vincoli di Bilancio nazionali per incrementare la spesa per la difesa, a causa della necessità (interna alla logica capitalista) di «una nuova era di investimenti strategici nelle capacità e nella prontezza di difesa europee, compreso lo sviluppo congiunto di capacità critiche di difesa [alias, nucleare?]»[17]. Fondamentale, sempre dal punto di vista del finanziamento, il fatto che le spese per la difesa saranno ricomprese entro il Fondo europeo per la competitività, nel tentativo di attrarre capitali privati anche per questo settore.
- Conclusioni
Il Bilancio è più di quanto abbiamo riportato. Di istruzione, giustizia, cultura e Pubblica Amministrazione non abbiamo parlato, nel tentativo di concentrarci sugli aspetti dirimenti. Purtroppo le innovazioni politiche introdotte dalle istituzioni comunitarie sono spesso surrettizie e non vengono riportate correttamente – e ancor meno, “compiutamente” – dai media nostrani, per cui si rendeva necessario focalizzarci sui punti cardine. E del resto quel che colpisce prima di ogni altra cosa, leggendo il Bilancio, è che si stiano compiendo passi politici enormi con una leggerezza incredibile, in gran silenzio, nascondendosi ad arte dietro le politiche nazionali degli Stati membri e il relativo dibattito, di cui però gli argomenti che abbiamo ivi trattato non fanno quasi mai parte. E non è un caso.
[1] Commissione Europea, Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro - Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034, COM (2025) 570 final/2, p. 3.
[2] Ivi, p. 30.
[3] Ivi, pp. 24 e 25.
[4] F. Bellisai, C. Scano, Aste EU ETS in Italia. Trasparenza e tracciabilità dei ricavi. ECCO: Report Febbraio 2025, p. 4.
[5] Un bilancio dell'UE dinamico ecc., p. 31.
[6] Ivi, p. 24.
[7] Ivi, p. 26.
[8] Ivi, p. 27.
[9] Così come si verifica, ad esempio, con le Direttive europee: è solo il mancato risultato che comporta l’avvio di procedure d’infrazione.
[10] Un bilancio dell'UE dinamico ecc., p. 6.
[11] Ivi, p. 10.
[12] Importanti Progetti Comuni di Interesse Europeo. Piani di sviluppo economico-industriale per i settori strategici dell’economia, che coinvolgono da un lato un gruppo di Paesi membri, dall’altro un gruppo di imprese leader, di questi Paesi. Diversi sono, ad esempio, gli Ipcei sulla Microelettronica.
[13] Un bilancio dell'UE dinamico ecc., p. 13.
[14] Ivi, p. 15.
[15] M. Draghi, Rapporto ‘Il futuro dell’Europa…’, p. 167.
[16] Nel Bilancio, ad esempio, si fa implicito riferimento all’Act in Support of Ammunition Production, che punta a rafforzare la produzione di munizioni.
[17] Un bilancio dell'UE dinamico ecc., p. 12.
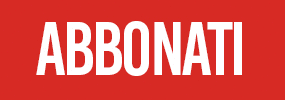

1.gif)