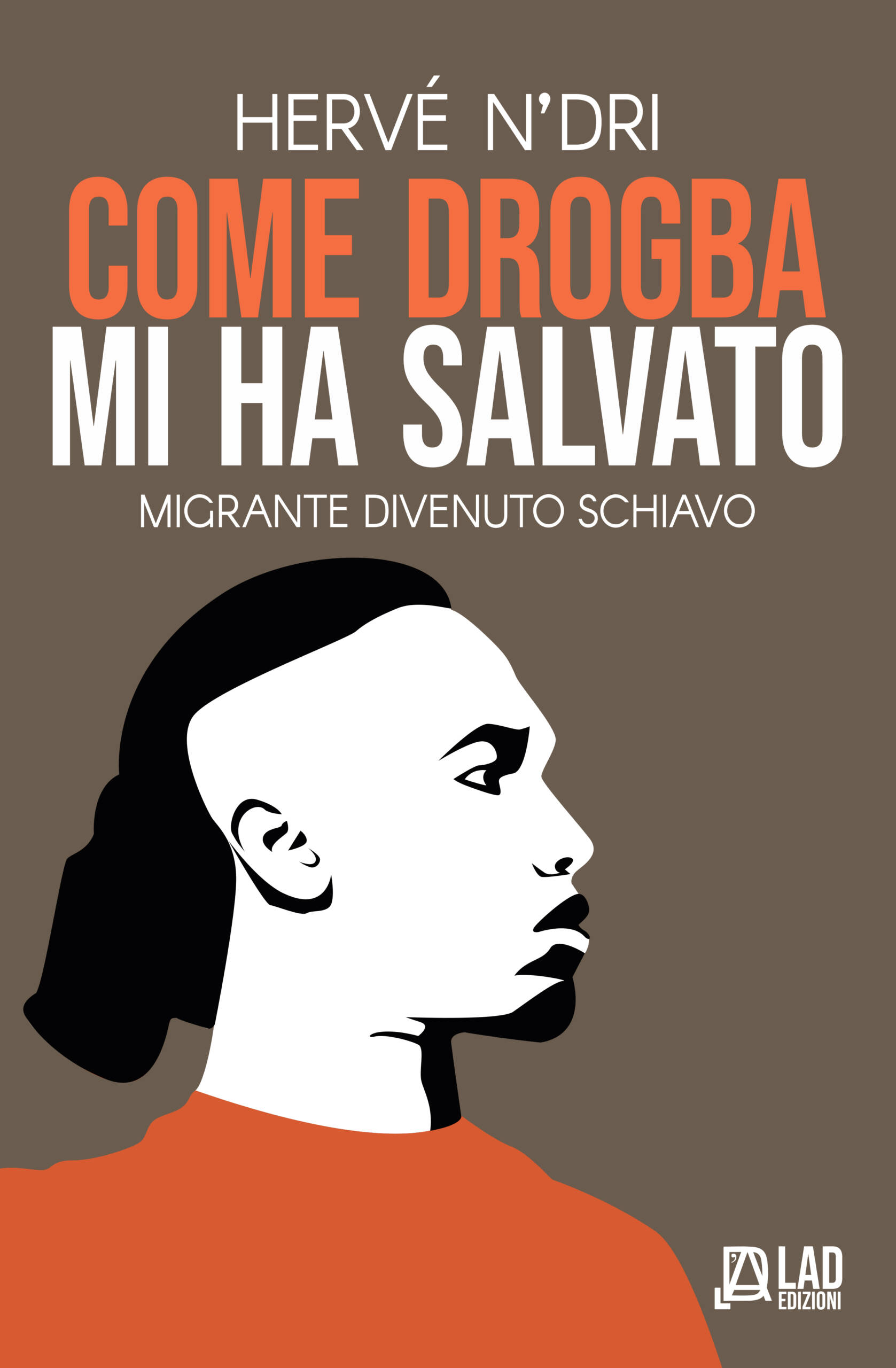La strategia globale dietro i dazi USA, secondo Stephen Miran
di Domenico Moro
I dazi stanno caratterizzando la seconda presidenza di Donald Trump. Tuttavia, il presidente sui dazi ha un comportamento ondivago, minacciando e sospendendo le tariffe per poi aumentarle o diminuirle.
Se vogliamo capire le cause profonde dei dazi e del comportamento ondivago di Trump dobbiamo staccarci dal contingente e cercare di capire qual è la strategia complessiva. A questo proposito, dobbiamo fare riferimento a Stephen Miran, che della politica dei dazi è lo stratega e che è attualmente il presidente del Council of Economic Advisor, un organismo interno all’Ufficio Esecutivo del Presidente degli Stati Uniti, il cui compito è dare consigli al presidente su temi economici. Durante la prima amministrazione Trump, Miran è stato consigliere senior del Ministero del Tesoro e successivamente stratega senior per Hudson Bay Capital Management, un grande investitore istituzionale all’interno del Trump Media & Technology Group, che gestisce anche la piattaforma Truth Social.
In particolare, dobbiamo fare riferimento a un testo di Miran che rappresenta il manifesto della politica dei dazi, A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System (Guida dell’utente alla ristrutturazione del sistema commerciale globale), che è stato pubblicato da Hudson Bay nel novembre del 2024 in contemporanea con la vittoria di Trump.
Introduzione
Cominciamo, quindi, a vedere cosa dice questo testo. Miran inizia imputando alla sopravvalutazione del dollaro la ragione del deficit commerciale con l’estero e del declino della manifattura statunitense. Miran si propone di individuare gli strumenti per ovviare a questi problemi. Lo strumento unilaterale più importante sono i dazi, che, contrariamente a quanto sostiene l’opinione comune, non necessariamente aumentano l’inflazione. Infatti, quando nel 2018-2019, durante il primo mandato Trump, furono alzati i dazi non ci furono apprezzabili aumenti dell’inflazione, anche perché i dazi furono controbilanciati dal rafforzamento del dollaro.
Un altro strumento è l’abbandono della politica del dollaro forte. La sopravvalutazione del dollaro, da una parte, ha creato deficit commerciali sempre più ampi e, dall’altra parte, ha penalizzato la manifattura statunitense, favorendo il settore finanziario. Questo non significa, però, abbandonare il ruolo del dollaro come valuta di riserva, ma che bisogna trovare dei modi per trattenere negli Usa una parte dei benefici che le altre nazioni ricevono dalla fornitura di riserve. Alla condivisione dei costi per la fornitura degli asset di riserva si deve aggiungere anche quella dei costi dell’ombrello di sicurezza che gli Usa forniscono ai loro alleati.
Le basi teoriche
Miran collega il declino della manifattura statunitense, dovuto alla sopravvalutazione del dollaro, al degrado delle comunità dove prima esistevano centri industriali. A seguito della deindustrializzazione, molte persone diventano dipendenti dall’elemosina di stato e dalle droghe o sono costrette a spostarsi verso luoghi più prosperi. Inizialmente si era stimato che fossero stati perduti 2 milioni di posti di lavoro, ma sono stati persi anche molti posti di lavoro che, pur non essendo manifatturieri, dipendevano dalla manifattura. La perdita della manifattura incide anche sulla sicurezza statunitense, evidenzia Miran, dal momento che il settore manifatturiero è necessario per contrastare l’ascesa non solo economica ma anche militare della Cina e della Russia: “Se non si hanno catene produttive con le quali produrre armi e sistemi difensivi, non si ha neppure sicurezza nazionale. Come il presidente Trump ha sostenuto: <<Se non hai acciaio, non hai un paese>>”i.
Ma, si chiede Miran, perché il dollaro non si svaluta in presenza di forti deficit commerciali, permettendo così il riequilibrio della bilancia commerciale? Normalmente, le valute dovrebbero adattarsi nel lungo periodo alla bilancia commerciale: se un paese registra un deficit commerciale prolungato la sua valuta si deprezza, facendo sì che le esportazioni aumentino e le importazioni diminuiscano, in modo da riequilibrare la bilancia commerciale. Un altro aspetto importante è la concezione di equilibrio finanziario. Secondo questa concezione, le valute si aggiustano fino a spingere gli investitori a detenere asset denominati in differenti valute.
Questi meccanismi, però, non funzionano se la valuta nazionale è un asset di riserva come nel caso del dollaro. Dal momento che gli Usa forniscono asset di riserva al mondo, la domanda di dollari e di titoli di stato statunitensi (USTs) non è dipendente né dal saldo commerciale né dalla ottimizzazione dei guadagni finanziari. Questi asset vengono detenuti a livello globale più per ragioni politiche che per l’ottimizzazione dei guadagni. Come affermò l’economista belga Robert Triffin, gli asset di riserva sono una funzione del commercio e del risparmio globale, non della bilancia commerciale o dei rendimenti dei titoli del paese che detiene la valuta mondiale.
Gli Usa, dunque, sopportano tale deficit non perché importano troppo, ma importano troppo a causa del fatto che devono esportare USTs per fornire asset di riserva e facilitare la crescita globale. Il deficit è tanto più difficile da sopportare quanto più il Pil degli Usa si riduce in rapporto a quello globale. Sempre secondo Triffin, arriva il punto in cui lo squilibrio economico diventa così ampio da minare lo status di moneta di riserva internazionale. Gli Usa, però, malgrado la loro quota del Pil mondiale si sia dimezzata dal 40% degli anni ’60 al 26% attuale, sono ancora lontani da questo pericolo, perché non ci sono alternative al dollaro, né da parte dello yuan renmimbi cinese, che non soddisfa i criteri richiesti da una valuta internazionale, come la piena convertibilità, né da parte dell’euro, visto che l’economia della zona-euro si è ridotta negli ultimi decenni più di quella degli Usa.
Di fronte alla riduzione relativa dell’economia statunitense, l’attuale assetto dei dazi statunitensi – il 3% medio, contro il 5% della Ue e il 10% della Cina-, risulta calibrato sulle caratteristiche di un’epoca molto diversa da quella attuale, in cui gli Usa si dovevano assumere l’onere di rilanciare l’economia europea e giapponese dopo la guerra e creare alleanze contro l’Urss.
Miran, a questo punto, individua le conseguenze dell’essere nazione detentrice di asset di riserva.
-
La possibilità di prendere a prestito a buon mercato. In realtà, non necessariamente gli Usa prendono a prestito in modo più economico degli altri paesi, ma possono prendere a prestito di più senza che il tasso d’interesse si spinga più in alto.
-
Una valuta più forte. La domanda di riserve spinge in alto il dollaro, molto più di quanto dovrebbe in base alla bilancia commerciale, sopravvalutandolo. Questo accade soprattutto in periodi di crisi, perché gli investimenti in dollari sono quelli più “sicuri”. Per questo l’occupazione nella manifattura declina drasticamente negli Usa durante una recessione, senza che si riesca a recuperarla nella fase di ripresa.
-
Extraterritorialità finanziaria. Avere la valuta di riserva permette agli Usa di esercitare la loro volontà nella politica estera e di sicurezza usando la forza finanziaria anziché quella fisica. Di fatto, le sanzioni, che gli Usa infliggono in tutto il mondo, grazie al fatto di essere detentori della valuta di riserva, sono una forma moderna di blocco navale.
Quindi, lo status di valuta di riserva offre solo un piccolo vantaggio in termini di economicità del prestito e un grosso svantaggio, in termini di sopravvalutazione del dollaro che erode la competitività delle merci statunitensi, compensato in parte, però, dal vantaggio geopolitico della possibilità di infliggere sanzioni. Ma gli Usa, in cambio dello status di valuta mondiale, forniscono alle democrazie liberali, oltre a un vasto mercato per le loro esportazioni manifatturiere, anche un altro servizio, l’ombrello difensivo. Deficit commerciali e difesa sono, quindi, legati attraverso la moneta. Tale situazione diviene più gravosa per gli Usa, dal momento che, riducendosi il loro peso relativo sull’economia mondiale, il deficit delle partite correnti cresce e la capacità di produrre equipaggiamenti militari viene meno. Per tutte queste ragioni negli Usa, sostiene Miran, c’è un crescente consenso a mutare le relazioni che li legano al resto del mondo.
Se gli Usa vogliono mutare lo status quo, allora devono trovare delle soluzioni. Generalmente soluzioni unilaterali hanno più probabilità di provocare effetti indesiderati, come la volatilità di mercato. Soluzioni multilaterali sono, invece, molto difficili, forse impossibili, da implementare, anche se, coinvolgendo nelle decisioni anche i paesi stranieri, aiutano a ridurre la volatilità. Il dollaro è asset di riserva non solo perché fornisce stabilità, liquidità, ampiezza di mercato e dominio della legge, ma anche perché gli Usa possono proiettare la forza fisica in tutto il mondo, modellando e difendendo l’ordine globale. L’intreccio tra status di valuta di riserva e sicurezza nazionale è storia di lunga data.
I dazi e le politiche valutarie permettono, secondo Miran, di migliorare la competitività della manifattura riallocando produzione e posti di lavoro negli Usa. I dazi non sono diretti a reinternalizzare quei settori per i quali altri paesi – ad esempio il Bangladesh nel tessile – hanno un vantaggio comparato, ma a preservare il vantaggio competitivo degli Usa nelle produzioni ad alto valore aggiunto. Inoltre, dal momento che le politiche commerciali e quelle di sicurezza sono intrecciate, i dazi tenderanno a difendere impianti industriali necessari alla sicurezza nazionale, il cui ambito va inteso in modo allargato, includendo ad esempio prodotti come i semiconduttori e i farmaci.
L’obiettivo non è quello di eliminare lo status di valuta di riserva del dollaro, per difendere il quale Trump ha minacciato di alti dazi quei paesi che dovessero abbandonarlo, ma quello di condividere con gli alleati il peso della fornitura di asset di riserva e dell’ombrello di difesa.
I dazi
Miran, inizialmente, si pone il problema della misura in cui i dazi sono controbilanciati dall’apprezzamento della valuta. Se il tasso di cambio e i dazi si compensano quasi completamente, i dazi non provocano alcun aumento dell’inflazione, ma non si verifica un ribilanciamento commerciale. Viceversa, se il tasso di cambio non compensa i dazi, le importazioni del paese sottoposto a dazi diventano più costose e, di conseguenza, ci sarà un qualche ribilanciamento dei flussi commerciali, ma anche prezzi più alti. Quindi, la scelta è tra bassa inflazione e riequilibrio commerciale. L’unico aspetto che non cambia nei due casi, è che i dazi generano importanti entrate fiscali.
La storia recente, come quella dei dazi imposti nella prima amministrazione Trump alla Cina, dimostra, secondo Miran, che non si verifica una crescita apprezzabile dell’inflazione, dal momento che lo yuan renmimbi all’epoca si deprezzò rispetto al dollaro del 13,7%, compensando gran parte dell’aumento dei dazi al 17,9%. Nel caso in cui la compensazione valutaria non si attui, i prezzi si alzeranno a seguito dei dazi e i consumatori ne sopporteranno il peso. Tuttavia, col tempo, gli alti prezzi incentiveranno una riconfigurazione delle catene di fornitura, i produttori statunitensi miglioreranno la competitività, vendendo di più sul mercato nazionale, e gli importatori saranno incentivati a trovare alternative ai prodotti importati che sono sottoposti ai dazi.
Diversa dal mercato delle merci è la situazione del mercato finanziario. Mentre riduce la volatilità dei prezzi al consumo, la compensazione valutaria può implicare una maggiore volatilità nei mercati finanziari, almeno nel breve periodo. Tuttavia, rileva Miran: “Ciò che importa è se c’è un effetto duraturo derivante dai dazi, visto che, come ogni investitore sa, le iniziali risposte del mercato spesso si annullano e vengono invertite col tempo.”ii
La più potente variabile finanziaria nello spiegare le variazioni valutarie nei mercati finanziari è lo spread dei tassi d’interesse. Nel periodo della guerra commerciale il vantaggio nei rendimenti dei titoli di stato Usa declinò da circa il 2% del gennaio 2018 a circa l’1,5% al momento dell’armistizio nella guerra commerciale nel settembre 2019, malgrado la Banca centrale statunitense avesse aumentato i tassi nel 2018. Rendimenti declinanti possono rendere più difficile l’apprezzamento del dollaro e, quindi, non compensare l’aumento delle tariffe, Tuttavia, Miran ritiene che la compensazione valutaria si realizzi nella prossima tornata di dazi.
Miran, a questo punto, volge la sua attenzione alle modalità di implementazione dei dazi. Un forte e improvviso aumento dei dazi può aumentare la volatilità dei mercati. Ma già nella prima presidenza Trump l’introduzione dei dazi avvenne in modo graduale: “Dal momento che i dazi sono uno strumento di negoziazione, il presidente fu volubile nella loro implementazione – l’incertezza riguardo a se, quando, e quanto grande aumenta la leva in una negoziazione, attraverso la creazione di paura e di dubbio.”iii Un tale approccio graduale aiuterà le imprese a ridefinire le catene di fornitura, facilitando lo spostamento delle produzioni al di fuori della Cina.
Un altro aspetto importante della implementazione dei dazi nel secondo mandato di Trump, sarebbe la segmentazione dei vari paesi in differenti gruppi con dazi differenti a seconda del rapporto che hanno con gli Usa, anche e soprattutto sul piano della difesa. Infatti, “I paesi che vogliono stare all’interno dell’ombrello di sicurezza devono stare anche all’interno dell’ombrello del commercio equo. Un tale strumento può essere usato per fare pressioni su altre nazioni affinché si uniscano ai nostri dazi contro la Cina, creando un approccio multilaterale ai dazi.”iv In questo modo, creando un muro globale di dazi attorno alla Cina, aumenterà la pressione su quest’ultima a riformare il suo sistema economico.
C’è, inoltre, la questione del rapporto tra dazi e tassazione. Secondo Miran la riduzione delle imposte, ad esempio sul lavoro, è uno strumento per generare investimenti e lavoro negli Usa, specie se finanziata con i dazi sulle importazioni estere. Le conseguenze economiche di un incremento dei dazi potrebbero essere meno problematiche di un incremento delle imposte sui redditi e sui capitali. Il fatto che i dazi prima aumentino il benessere e poi lo diminuiscano, implica l’esistenza di un tasso dei dazi “ottimale”, al livello del quale un paese ha ottenuto tutto il possibile beneficio e un dazio più alto riduce il benessere. Il dazio ottimale, secondo Miran, è per gli Usa al 20%. Altra questione è l’eventuale rappresaglia dei paesi a cui gli Usa impongono i dazi, che può portare a una escalation ben al di là dei dazi ottimali. Tuttavia, gli Usa, dal momento che sono di gran lunga la maggiore fonte di domanda mondiale con un forte mercato dei capitali, possono resistere a una escalation più della Cina.
Un altro deterrente nei confronti di ritorsioni sui dazi è la minaccia di dichiarare meno vincolanti gli obblighi di mutua difesa, non garantendo più l’ombrello nucleare statunitense. Ad esempio, se l’Europa impone dei contro-dazi alle importazioni dagli Usa, ma nello stesso tempo aumenta le spese militari, ciò permette agli Usa di alleviare il carico per la sicurezza globale e “di concentrarsi maggiormente sulla Cina che è di gran lunga la più grande minaccia per l’economia e la sicurezza nazionale dell’America di quanto lo sia la Russia, e questo generando allo stesso tempo entrate.”v
Ad ogni modo, i dazi sono uno strumento per alzare le tasse sugli stranieri in modo da mantenerle basse sugli statunitensi e per evitare che il prolungamento della riduzione delle imposte sui redditi si traduca in nuovo debito pubblico.
Le valute
Alla sopravvalutazione del dollaro si può rispondere, oltre che con i dazi, rivalutando le valute dei partner commerciali. Le politiche valutarie, però, presentano il problema di rendere meno attrattivi gli asset in dollari agli occhi degli investitori stranieri. Una svalutazione del dollaro potrebbe causare un flusso in uscita su larga scala dal mercato dei titoli di stato statunitensi, che darebbe luogo ad un innalzamento dei rendimenti sul lungo periodo. Ciò si scaricherebbe negativamente su diversi settori dell’economia, a partire dall’edilizia.
Tale rischio aumenterebbe nel caso in cui l’inflazione rimanesse elevata e la banca centrale statunitense (Fed) decidesse di innalzare i tassi d’interesse. Per questa ragione sarà importante per l’amministrazione Trump coordinare la politica valutaria con una politica regolatoria e energetica deflazionistica. Inoltre, una porzione significativa delle vendite delle imprese tra le prime 500 S&P avviene all’estero e quelle vendite hanno più valore quando il dollaro si deprezza.
Storicamente gli accordi valutari multilaterali sono stati la via principale per guidare i cambiamenti intenzionali del tasso di cambio del dollaro. Uno di questi fu l’accordo del Plaza nel 1985, quando gli Usa, d’accordo con Francia, Regno Unito, Germania Occidentale e Giappone, coordinarono l’indebolimento del dollaro. Oggi le valute più importanti, oltre al dollaro, sono l’euro e lo yuan cinese, ma ci sono poche ragioni per aspettarsi che Europa e Cina siano d’accordo a rafforzare le loro valute. Secondo Miran, è possibile che Europa e Cina diventino più malleabili dopo una serie di dazi punitivi e accettino qualche forma di accordo valutario in cambio di una riduzione dei dazi. Miran propone di chiamare un accordo di questo tipo come l’accordo “Mar-a-Lago”, dal nome della residenza di Trump in Florida.
Le differenze tra oggi e il 1985 sono, però, molte. A partire dall’entità del debito pubblico statunitense, all’epoca al 40% del Pil oggi al 120%, il che pone maggiori problemi di gestione dell’aumento dei rendimenti dei titoli di stato. La soluzione sarebbe quella di motivare la riduzione dei tassi con la necessità di finanziare la fornitura da parte degli Usa dell’ombrello di sicurezza. In questo modo, i paesi partner saranno incentivati a cambiare i loro USTs a breve termine con USTs centenari. La durata più lunga aiuterà a ridurre i rendimenti e la volatilità del mercato finanziario. Quindi, con un solo accordo si raggiungono più obiettivi: ridurre il valore del dollaro, riducendo così il deficit commerciale, e condividere con gli stranieri il costo della zona di sicurezza.
Tutto questo funziona se i paesi partner coinvolti hanno asset in dollari da vendere per ridurre il valore del dollaro. A differenza del 1985 oggi le riserve di USTs non sono collocate in Europa ma in Medio Oriente e in Asia orientale specialmente in Cina, Giappone e Arabia Saudita. Questi paesi sarebbero meno disponibili a soddisfare le richieste degli Usa rispetto agli europei del 1985. Pertanto, sarebbe bene, che gli strumenti valutari siano usati dopo i dazi, che forniscono una leva ulteriore nella negoziazione.
Molti a Wall Street pensano che non ci possano essere approcci unilaterali alla svalutazione del dollaro, perché questa richiederebbe il taglio dei tassi d’interesse da parte della Fed, cosa che non sembra possa accadere così facilmente. In realtà, questo non è vero, perché c’è una serie di strumenti che si possono utilizzare. Uno di questi è l’International Emergency Economic Power Act (IEEPA) del 1977. Se la causa della sopravvalutazione del dollaro è la domanda di asset di riserva, si può usare la IEEPA per diminuirla, per esempio con una user fee (tassa dell’utilizzatore), trattenendo una parte del pagamento degli interessi su quei titoli.
Questo, però, potrebbe determinare una fuga dal dollaro, picchi dei tassi d’interesse e limitazioni al potere di extraterritorialità. Per evitare tali problemi si può partire con una modesta user fee, per poi trovare col tempo il “giusto” livello, e differenziare a seconda dei paesi, come già fatto con i dazi, aumentando la user fee agli avversari geopolitici come la Cina, ad esempio, e, infine, assicurarsi la cooperazione volontaria della Fed. A questo proposito, è decisivo che il mandato “duale” della Fed sia un mandato triplo: massima occupazione, prezzi stabili e tassi di interesse moderati sul lungo termine. L’ultimo di questi impegni consente di intervenire se i tassi di interesse raggiungono il picco come risultato della politica valutaria.
Un altro approccio unilaterale è il rafforzamento delle valute estere, attraverso la vendita di dollari e l’acquisto di valute estere. In questo caso, un rischio è rappresentato dall’inflazione che può essere generata dalla emissione massiccia di dollari da parte della Fed per acquistare valuta estera. In questo caso la Fed può operare per una sterilizzazione dell’intervento che sosterrà il dollaro e contrasterà alcuni effetti delle vendite. Per queste ragioni gli economisti si sono detti scettici a usare questo mezzo per intervenire sulla valuta. Dunque, molto dipenderà dal contesto in cui questa politica viene adottata: nel contesto di una bassa inflazione c’è margine per una contenuta sterilizzazione.
Considerazioni su mercato e volatilità
Secondo Miran, il presidente Trump nel suo secondo mandato potrà concentrarsi sui suoi obiettivi centrali: reindustrializzazione, rivitalizzazione della manifattura e miglioramento della competitività internazionale. Sui dazi Trump ha fatto una discreta esperienza nel suo primo mandato, mentre intervenire sulla politica sul dollaro sarebbe una cosa nuova.
Per questa ragione, riguardo alle politiche valutarie bisogna essere più cauti che con le politiche sui dazi, e aspettare che inflazione e deficit siano bassi, per evitare aumenti dei tassi d’interesse che potrebbero accompagnarsi a un mutamento della politica sul dollaro, e soprattutto aspettare un avvicendamento alla guida della Fed che ne garantisca la volontaria cooperazione. Dal momento che una bassa inflazione è necessaria per permettere alla Fed di tagliare i tassi, si dovrà ricorrere a politiche strutturali, attraverso liberalizzazioni dell’offerta, deregolamentazioni e riduzione dei prezzi dell’energia.
Gli approcci valutari unilaterali presentano maggiori rischi di volatilità. Senza l’assistenza della Fed nel fissare un tetto ai rendimenti, e senza la disponibilità dei detentori stranieri dei USTs a rinegoziare la durata del debito, una amministrazione ha poche opzioni per stabilizzare i rendimenti.
Per queste ragioni un approccio multilaterale per rafforzare le valute sottovalutate può aiutare a contenere la volatilità indesiderata. Un accordo in cui i partner commerciali degli Usa tramutino le riserve in loro possesso in USTs di lunghissima durata allevierà la pressione del rifinanziamento sul Tesoro, migliorerà la sostenibilità del debito, e rafforzerà il concetto che fornitura di asset di riserva e dell’ombrello di difesa sono intrecciate. In questo modo, il dollaro e i rendimenti sul lungo periodo possono scendere insieme.
In tutti i possibili scenari ci sono delle conseguenze comuni. In primo luogo, si attua una netta demarcazione tra amici, nemici e neutrali. Gli amici sono quelli che stanno dentro l’ombrello di sicurezza e economico, condividendone i costi. Chi sta al di fuori dell’ombrello di sicurezza si troverà anche fuori da intese commerciali amichevoli. In secondo luogo, l’espulsione di paesi esteri dalla copertura dell’ombrello di sicurezza Usa può portare a un aumento della percezione di pericolo e, quindi, all’aumento dei premi per il rischio per gli asset di quei paesi. In terzo luogo, si verificherà un aumento della volatilità sui mercati valutari. In quarto luogo, si intensificheranno gli sforzi per trovare una alternativa al dollaro. A tal proposito, Miran è convinto che continueranno a fallire sia i tentativi di internazionalizzare lo yuan sia quelli di creare una valuta dei Brics, ma che è, invece, possibile che si rafforzino l’oro e le criptovalute.
Le conclusioni di Miran
Miran ribadisce che il suo è un tentativo di individuare dei sistemi per ovviare al deficit commerciale e pubblico, evitando effetti collaterali indesiderati. L’opinione di Wall Street secondo cui non si può modificare volutamente il valore del dollaro è falsa. Ci sono molti modi, unilaterali e multilaterali, l’importante è minimizzare la conseguente volatilità. Ad ogni modo, è altamente probabile che i dazi, essendo un importante strumento negoziale, vengano usati prima di ogni strumento valutario. Pertanto, è probabile che il dollaro si rafforzi, prima di invertire il suo andamento, sempre che lo faccia. Miran conclude dicendo che “C’è una strada attraverso la quale l’amministrazione Trump può riconfigurare il commercio e i sistemi finanziari globali a beneficio dell’America, ma questa strada è stretta e richiederà attenta pianificazione, esecuzione precisa e attenzione alle azioni da intraprendere per minimizzare le conseguenze avverse.”vi
Le nostre conclusioni
La lettura del testo di Miran è molto interessante, perché combacia in gran parte con quanto ha fatto e detto fino ad ora Trump, spiegandone la logica interna e inquadrandola nella ridefinizione dei rapporti tra Usa e resto del mondo, a partire dagli alleati. Il che, dato che gli Usa sono la maggiore economia e il maggiore compratore mondiale, implica, come Miran anticipa già nel titolo, la ristrutturazione del sistema di commercio globale.
L’aspetto che più colpisce è che Miran veda il ruolo del dollaro di valuta di riserva internazionale e il ruolo degli Usa di potenza militare garante dell’ordine mondiale come un servizio che generosamente gli Usa offrono agli altri paesi. Un servizio che costa agli Usa la deindustrializzazione, un largo deficit commerciale e un enorme debito federale. Gli altri paesi sono, dunque, degli scrocconi, come hanno più volte affermato Trump e il suo vice-presidente, J.D. Vance, in riferimento all’Europa, la quale beneficerebbe gratuitamente dell’ombrello di sicurezza e del mercato statunitense.
Il fatto, però, è che l’interpretazione di Miran rovescia la realtà effettiva delle cose. La deindustrializzazione è soprattutto un prodotto delle logiche interne del modo di produzione capitalistico e in particolare della caduta tendenziale del saggio di profitto. Le corporation giganti degli Usa hanno spostato una parte considerevole della produzione all’estero, perché all’estero – in Messico, in Cina e nell’Asia orientale – i profitti erano maggiori e il costo del lavoro più basso. La sopravvalutazione del dollaro certamente ha inciso, ma in misura più limitata di quanto Miran sostiene.
Ma l’aspetto più importante è che il dollaro e il suo ruolo di valuta di scambio commerciale e di riserva mondiale non sono un peso bensì l’“esorbitante privilegio” degli Usa, come sostenne l’ex presidente francese Giscard d’Estaing. È tale privilegio che gli ha permesso di finanziare il doppio debito, commerciale e pubblico, semplicemente stampando dollari. Le enormi spese militari sono funzionali a imporre in modo coercitivo l’egemonia statunitense e lo stesso ruolo internazionale del dollaro. Non è, quindi, un caso che il segretario statunitense del Tesoro, John Connally, affermasse che “il dollaro è la nostra valuta e il vostro problema” nel 1971, quando gli Usa resero il dollaro inconvertibile in oro, dandosi così la possibilità di indebitarsi a proprio piacimento.
Ma, se il dollaro è lo strumento che consente agli Usa di gestire il doppio debito, qual è la ragione dell’introduzione di forti dazi e di politiche orientare a svalutare il dollaro? La ragione, sempre seguendo il ragionamento di Miran, sta nel fatto che queste politiche contrastano le delocalizzazioni e favoriscono le rilocalizzazioni della manifattura. Infatti, dice sempre Miran, senza manifattura non c’è sicurezza nazionale, specialmente se questa è intesa in senso lato, come autonomia nelle produzioni strategicamente importanti, come quelle di acciaio, semiconduttori e farmaci. Del resto, la guerra in Ucraina ha messo a nudo le gravi insufficienze dell’industria bellica statunitense nel rifornire Zelensky di armi e munizioni, aggravate dall’aiuto che gli Usa contemporaneamente hanno offerto a Israele.
Una industria bellica più forte è necessaria perché – ed è questo l’altro punto importante del ragionamento di Miran – i rapporti di forza economici e politici si sono modificati negli ultimi anni. In particolare, la Cina è cresciuta fino al punto di diventare “di gran lunga la più grande minaccia per l’economia e la sicurezza nazionale dell’America di quanto sia la Russia”. Dal momento che la Cina ha una manifattura fortissima e ora anche tecnologicamente avanzata, gli Usa non possono permettersi di avere una manifattura debole e non all’avanguardia.
Un altro aspetto importante è rappresentato dalla sostenibilità del debito pubblico degli Usa e quindi dal livello dei tassi d’interesse sugli USTs. Come abbiamo visto, Miran, sempre nell’ottica di risolvere il deficit commerciale e rilanciare la manifattura, sostiene che il dollaro debba essere svalutato o, il che è lo stesso, debbano essere rivalutate le valute dei principali partner economici, a partire dallo yuan e dall’euro. Ora, il problema è che la svalutazione del dollaro rende meno attrattivi gli investimenti in dollari, compresi quelli negli USTs e ciò rialza i rendimenti. L’optimum per gli Usa sarebbe, invece, un dollaro svalutato e tassi d’interesse bassi sul debito pubblico.
Oggi, però, accade che il dollaro da inizio anno si è svalutato nei confronti delle principali valute del 13%, mentre i tassi d’interesse sul debito a 10 anni sono saliti dall’1,1% del 2021 a circa il 4,3% di luglio 2025. A questo si aggiunge, sotto la presidenza Biden, il maggiore aumento del debito pubblico mai registrato, ben 8,5 trilioni di dollari in più. La tendenza sotto Trump non sembra invertirsi, data l’entità del budget federale per il 2026, che, tra le altre ragioni, ha portato alla rottura tra Trump e Musk. L’aumento dei tassi e del debito pubblico hanno fatto esplodere la spesa netta per gli interessi: dai 658 miliardi di dollari del 2023 agli 880 del 2024 fino a oltre un trilione previsto per il 2025, cioè tre volte i livelli del 2020vii.
Per queste ragioni, Miran sottolinea più volte la necessità che la Fed rispetti un triplice mandato, aggiungendo alla massima occupazione e ai prezzi stabili anche il perseguimento di tassi di interesse moderati sul lungo termine. Non è un caso che in questi ultimi mesi Trump abbia attaccato duramente il presidente della Fed, Jerome Powell, per non aver abbassato i tassi d’interesse. Sempre legata al tasso d’interesse sul debito federale, è la proposta di Miran di arrivare a un accordo, da lui chiamato accordo di Mar-a-Lago, con i partner economici per una svalutazione concertata del dollaro che contempli anche un passaggio da USTs a breve scadenza a USTs a lunghissima scadenza, che rendano per gli Usa meno oneroso il finanziamento del debito.
Ritorniamo, quindi, ai dazi, che, secondo il ragionamento di Miran, sono soprattutto un mezzo di negoziazione per imporre due obiettivi: svalutare il dollaro e finanziare il debito pubblico. I dazi possono essere messi e tolti o ridotti se gli altri paesi accettano le condizioni imposte dagli Usa, come l’apprezzamento delle loro valute, l’accettazione di acquistare debito a lunghissima scadenza e fare investimenti produttivi sul suolo americano. Un altro importante mezzo di negoziazione è la minaccia di togliere l’ombrello di sicurezza ai paesi che non rispettano le condizioni poste dagli Usa. Anche il comportamento ondivago sui dazi di Trump è spiegato da Miran con l’intenzione di aumentare la leva negoziale, creando dubbio e paura attraverso l’incertezza. In definitiva, i dazi, le politiche valutarie, l’ombrello di sicurezza, sono tutte espressioni di una politica ricattatoria con la quale gli Usa cercano di farsi finanziare dal resto del mondo, inclusi i loro alleati. Si tratta di un comportamento parassitario, basato sull’accumulazione per espropriazione e tipico della fase imperialista del capitalismo.
A questo punto viene naturale chiederci: le politiche ipotizzate da Miran avranno successo? È una domanda importante, perché in caso di successo o di insuccesso il mondo davanti al quale ci troveremmo nei prossimi decenni potrebbe essere molto diverso. È, però, una domanda a cui è difficile rispondere oggi, dopo solo sei mesi di amministrazione Trump, anche perché le variabili da considerare sono molte.
Possiamo, però, azzardare alcune previsioni. Riguardo alla rilocalizzazione manifatturiera qualcosa già si sta muovendo, dal momento che le prime 10 multinazionali farmaceutiche, a fronte della prospettiva di alti dazi, hanno annunciato 316 miliardi di dollari di nuovi investimenti per rilocalizzazioni sul suolo statunitenseviii. Un altro esempio, a questo proposito, è rappresentato dal Giappone, che, in cambio di una riduzione dei dazi al15%, ha promesso 550 miliardi di dollari di investimenti negli Usaix. A proposito dello status del dollaro, è possibile che la sua quota sulle riserve mondiali, attualmente al 57,74%x, si eroda ulteriormente, anche perché l’uso spregiudicato che ne è stato fatto per infliggere sanzioni, e la tattica ondivaga di Trump sui dazi lo hanno indebolito. Dall’altro lato, i Brics stessi hanno riconosciuto che una loro valuta comune non è fattibile, ma allo stesso tempo hanno dichiarato di voler utilizzare sempre di più le loro valute nazionali come strumento di transazione commerciale internazionale. Del resto, questo accade già dall’inizio della guerra in Ucraina negli scambi di materie prime energetiche tra la Russia, da una parte, e Cina e India, dall’altra.
Ad ogni modo, come sostiene Miran, gli Usa hanno poco margine per politiche valutarie alternative se la Fed non taglia i tassi e soprattutto se a livello globale le condizioni poste dagli Usa non vengono accettate. È proprio questo il problema principale per gli Usa. Molta parte del mondo, quella che viene definita “Sud globale”, non sembra più disposta a sottomettersi all’Occidente e in particolare agli Usa. Questo vale soprattutto per la Cina e la Russia, ma vale anche per il Brasile e molti altri paesi. In particolare, Cina e Brasile hanno risposto a muso duro quando Trump ha minacciato dazi altissimi. La stessa espansione dei Brics dimostra la volontà di un numero sempre maggiore di Stati di trovare sedi di confronto e cooperazione alternative rispetto a quelle che gli Usa e l’Occidente collettivo hanno offerto nel passato.
Diversa è la situazione dell’Occidente collettivo, a cui appartengono l’Europa occidentale e il Giappone. I paesi che ne fanno parte sembrano quelli più permeabili alle politiche ricattatorie di Trump e disponibili a venirgli incontro, anche perché dal sistema economico globale, organizzato attorno agli Usa, traggono ampi benefici. Ne sono la prova la sottomissione registrata all’ultimo vertice della Nato, quando l’Europa ha accettato di alzare la sua spesa militare a ben il 5% sul Pil, e la riluttanza della Ue a prospettare dei contro-dazi di risposta nei confronti di Trump, giustificata con il mantra “bisogna evitare una guerra commerciale con gli Usa”. Una guerra commerciale o meglio un confronto interimperialistico, si sarebbe detto un tempo, che in realtà è già in corso. A tal proposito, sembra che l’unità dell’Occidente sia un qualcosa cui Trump attribuisce un valore molto inferiore a quello che gli attribuisce la Meloni.
i Stephen Miran, A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System, Hudson Bay Capital, 24 November 2024 p.5.
ii Ibidem, p. 19.
iii Ibidem, p. 22.
iv Ibidem, p. 23.
v Ibidem, p.26.
vi Ibidem, p.38
vii Peter G. Peterson Foundation, What are Interest costs on the national debt? 14 July 2025. Committee for a responsible Federal Budget, Interest costs could explode from high rates and more debt, 20 May 2025.
viii Monica D’Ascenzo, “Effetto dazi sulla farmaceutica: 316 miliardi investiti negli Usa”, Il Sole24ore, 23 luglio 2025.
ix Stefano Strani, “Dazi, accordo Stati Uniti-Giappone: tariffe al 15% e Tokio investirà 550 miliardi negli Usa, Il Sole24ore, 24 luglio 2025.
x IMF data, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (Cofer), 2025 Q1.
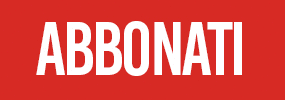

1.gif)