Decostruire il diritto, liberare la Palestina
di Pasquale Liguori*
Nel racconto dominante, quando diventa troppo scomodo difenderla apertamente, la violenza estrema di Israele contro i palestinesi viene derubricata a deviazione momentanea dal diritto internazionale: un’eccezione tollerabile, una sospensione temporanea dell’ordine giuridico globale, un errore morale da stigmatizzare con qualche sanzione di rito. E se il diritto internazionale fosse già ontologicamente selettivo, funzionale a tutelare gli interessi geopolitici, economici e razziali di Israele e del suo alleato occidentale? Se il fallimento del diritto non fosse tale, ma piuttosto genuina espressione della sua forma reale, della sua coerenza storica?
Israele non agisce in un vuoto normativo, ma in un quadro giuridico che implicitamente autorizza e sostiene il suo operato. Il genocidio in atto non avviene nonostante il diritto internazionale, ma in coabitazione con esso. L’impunità protratta, il sostegno incondizionato di Stati Uniti e Unione Europea, il linguaggio diplomatico che evita la parola “genocidio” mentre scorrono le immagini di crimini sistematici: tutto ciò segnala che non siamo davanti a una sospensione delle regole, ma al loro autentico funzionamento.
Riarticolando concetti di Giorgio Agamben, potremmo osservare l’eccezione nel suo affermarsi norma e, in un ulteriore passo critico, suggerire che essa è sempre stata la norma - almeno nei confronti dei soggetti colonizzati, discriminati, esclusi. La Palestina, allora, non è laboratorio dell’unicum: è il luogo in cui l’infrastruttura coloniale e normativa dell’Occidente si palesa in forma nuda, senza pudore.
Appare necessaria una rilettura complessiva del diritto internazionale non come luogo di giustizia universale, ma come dispositivo morale e giuridico costruito per salvaguardare i rapporti di potere globali. Il genocidio dei palestinesi con la complicità silente o attiva delle “democrazie” liberali non è quindi l’anomalia: è regola, e tale regola va decostruita. Da ciò deriva che smettere di parlare di fallimento del diritto è un atto politico: significa riconoscere che il diritto stesso è parte del problema. E se così è, allora ogni lotta anticoloniale e di liberazione non può che passare per una decostruzione radicale di quel diritto, per immaginare nuove forme di legalità che nascano dal basso, dalla solidarietà, dalla disobbedienza.
Il principio di sovranità statale, fondamentale nel diritto internazionale, ha sempre avuto una funzione ambivalente: garantire l’autonomia degli Stati europei, mentre veniva negata la sovranità a interi continenti considerati primitivi, arretrati, o semplicemente “fuori dalla civiltà”. Uno strumento per distinguere tra chi poteva essere titolare di diritti - il soggetto sovrano europeo - e chi invece poteva essere colonizzato, amministrato, sterminato.
La retorica della civilizzazione è stata l’abito morale del diritto internazionale per secoli: le guerre coloniali venivano giustificate come operazioni per portare ordine, progresso, diritto. Questo dispositivo moralizzante ha continuato a operare anche dopo le decolonizzazioni formali: la protezione dei diritti umani, le guerre umanitarie, le “interferenze giuste” sono tutte estensioni dello stesso meccanismo - una grammatica giuridica e morale che legittima l’intervento occidentale come atto civilizzatore e delegittima ogni resistenza come fanatismo, terrorismo, o barbarie.
Dopo il 1945, con la creazione dell’ONU e la proclamazione dei diritti umani universali, si sarebbe potuto pensare a una svolta. In realtà, si è trattato di una riconfigurazione del diritto coloniale in chiave liberale: un “nuovo ordine internazionale” che manteneva le gerarchie di potere, pur mascherandole sotto il velo dell’universalismo. I tribunali internazionali, le convenzioni, le sanzioni, i riconoscimenti diplomatici: tutti strumenti che continuano ad applicarsi selettivamente.
In questo quadro, Israele si inserisce non come eccezione ma come ereditarietà coloniale perfettamente integrata. È lo Stato-nazione che incarna, con assoluta lucidità, le contraddizioni e le continuità del diritto coloniale. Non a caso, il sionismo politico moderno nasce con lo stesso linguaggio dei grandi progetti imperiali europei: la terra promessa da “redimere”, il deserto da “far fiorire”, gli “indigeni” da spostare, contenere o far sparire.
Come ha sottolineato spesso il pensiero postcoloniale, la legge internazionale non protegge chi è fuori dalla sua comunità morale di riferimento. Ecco perché non si può parlare oggi di fallimento del diritto di fronte al genocidio palestinese: piuttosto, assistiamo a una sua applicazione strutturale. I palestinesi sono esclusi dalla comunità morale giuridica dell’Occidente, e quindi ogni loro vita diventa sacrificabile, ogni loro morte classificabile come “effetto collaterale”, ogni resistenza come minaccia all’ordine legittimo.
La Palestina rappresenta il paradigma massimo dell’eccezione come forma ordinaria. Non si tratta di una sospensione temporanea delle regole internazionali, ma di un regime permanente in cui la legge viene ritirata solo per lasciare spazio a un’entità che esercita violenza legittimata. In questo contesto, Israele agisce all'interno di un’eccezione giuridica che è ormai divenuta struttura, dispositivo, routine. Il potere si esercita senza limiti, ma in forme perfettamente organizzate e formalizzate, attraverso un apparato legale che codifica l’oppressione come norma.
La Striscia di Gaza, i Territori Occupati, i campi profughi, i checkpoint, le demolizioni, gli arresti extragiudiziali, le uccisioni sistematiche: tutto contribuisce alla creazione di uno spazio in cui la distinzione tra guerra e pace, diritto e crimine, occupazione e sicurezza, collassa quotidianamente in una zona grigia che rende possibile l’assassinio, l’assedio, l’espulsione e l’annientamento senza che ciò implichi responsabilità giuridiche effettive per Israele. Ciò che è finalizzato quotidianamente alla de-soggettivazione del palestinese. Per dirla con Achille Mbembe, è necropolitica: “la sovranità come capacità di decidere chi può vivere e chi deve morire”.
In questa necropolitica legalizzata, il diritto internazionale non è assente: è presente in quanto residuo simbolico, come linguaggio da evocare quando serve giustificare, ridimensionare o differire la condanna. Ogni crimine viene poi negato, minimizzato o rinviato alla diplomazia. Risoluzioni, trattati, condanne restano privi di effetti materiali, una moltitudine di appelli alle Nazioni Unite si arenano in risoluzioni non vincolanti e altrettanti tentativi di azione presso la Corte Penale Internazionale sono ostacolati da potenze che dettano la grammatica giuridica globale. Questa debolezza selettiva si rivela funzionale alla riproduzione dell’ordine esistente e conferma che alcuni Stati possono permettersi l’impunità, mentre altri devono obbedire alla norma.
Israele è dunque non al di fuori del diritto, ma dentro un diritto che ha imparato a piegare sistematicamente a proprio favore, in stretta alleanza con le architetture del potere occidentale. È qui che la relazione coloniale verso corpi razzializzati, territori e popoli sacrificabili si manifesta con chiarezza: l’Occidente, pur conoscendo nel dettaglio i crimini, li declassa moralmente attraverso l’uso selettivo delle categorie giuridiche. E quindi non si parla di “genocidio”, ma di “conflitto”; non di “occupazione illegale”, ma di “diritto alla difesa”; non di “apartheid”, ma di “tensione etnica”. Dunque, un’eccezione che si consolida e diventa architettura legale, nuova “normalità”.
Di fronte all’impunità sistematica con cui Israele conduce un’operazione coloniale e genocida contro il popolo palestinese, la reazione più comune è parlare di fallimento del diritto internazionale. Si invocano le Nazioni Unite, le Convenzioni di Ginevra, la Corte Penale Internazionale, le risoluzioni ignorate. Tuttavia, questo tipo di lettura, seppur mosso da (ingenua) indignazione, rischia di rafforzare un mito: quello di un diritto internazionale giusto, neutro, uguale per tutti, che sarebbe semplicemente mal applicato o in crisi. Perché, invece, non domandarsi se sia proprio questa retorica del fallimento a mascherare la funzione reale del diritto?
Lungi dall’essere uno strumento di emancipazione universale, il diritto internazionale si è storicamente costituito come un apparato di razionalizzazione del potere, costruito per regolare l’ordine globale secondo gerarchie razziali, coloniali e geopolitiche. La sua stessa architettura - con i suoi organi, le sue eccezioni procedurali, il peso degli Stati nella sua applicazione - lo rende intrinsecamente dipendente dai rapporti di forza. Non esiste un diritto “al di sopra” della politica: esiste solo un diritto che esprime e protegge determinate configurazioni del potere.
L’impunità di Israele è garantita da una struttura giuridica che lo protegge, non da una sua assenza. Il diritto è presente, ma articolato in modo da non disturbare i rapporti geopolitici fondamentali. La nozione di “crimine” diventa flessibile, sospesa, dislocata. Le risoluzioni non vincolanti, i processi mai avviati, gli appelli diplomatici: tutto costruisce un apparato retorico che simula il conflitto con la violenza, ma in realtà la tollera — e spesso la premia. L’impunità di Israele non è dunque un bug, ma una feature del sistema. La sua posizione strategica, il sostegno incondizionato degli Stati Uniti, l’allineamento ideologico con l’Europa liberale, fanno sì che qualsiasi condanna giuridica resti priva di effetti. L’Occidente, che si presenta come garante del diritto, si rivela essere l’eccezione incarnata: capace di applicare il diritto contro i nemici, ma di sospenderlo per sé e per i propri alleati.
L’apparato legale globale non ha bisogno di riforme: ha bisogno di una rottura epistemica.
Una rottura che comincia con il disincanto. Riconoscere che la giustizia non verrà da una Corte, da una Risoluzione, da una Commissione. Che il diritto non è neutro e che non può essere il fondamento delle lotte per la liberazione, se non quando viene radicalmente reimmaginato e rifondato a partire dai corpi, dalle comunità e dai popoli oppressi. Non si tratta di abbandonare il campo del diritto, ma di rifiutare il suo feticismo. Il diritto, per diventare strumento di liberazione, deve essere destrutturato e rifondato a partire dai soggetti storicamente esclusi. Deve diventare un diritto “disobbediente” all’ordinatore attuale.
Questo non significa abbandonare la dimensione giuridica, ma restituirla a chi ne è stato espulso. Significa trasformare il diritto da codice di esclusione in strumento di conflitto: un diritto che non chiede riconoscimento, ma che impone visibilità; che non supplica giustizia, ma la reclama come atto politico. In questo senso, il diritto internazionale non è oggi lo spazio in cui si gioca la liberazione palestinese, ma uno dei terreni di scontro in cui la battaglia per la legittimità della memoria, della resistenza e per la vita si deve necessariamente combattere. Il genocidio palestinese, rivelandone i limiti, ci obbliga a immaginare non la riforma del diritto, ma la sua trasformazione radicale, dal basso, dentro e contro l’ordine imperiale che lo governa.
*Fotografo dei contesti di edilizia residenziale pubblica e della città ai suoi bordi. Ha pubblicato due volumi - “Borgate” e “ImpAsse Roma-Berlino” - ed effettuato mostre in Italia e all’estero in musei, enti istituzionali e centri sociali. Collabora con riviste indipendenti di politica e architettura ed è autore di saggi riguardanti la periferia, la fotografia urbana e sociale. È impegnato in attività antimperialiste, decoloniali e di sostegno umanitario.
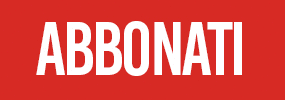

1.gif)
