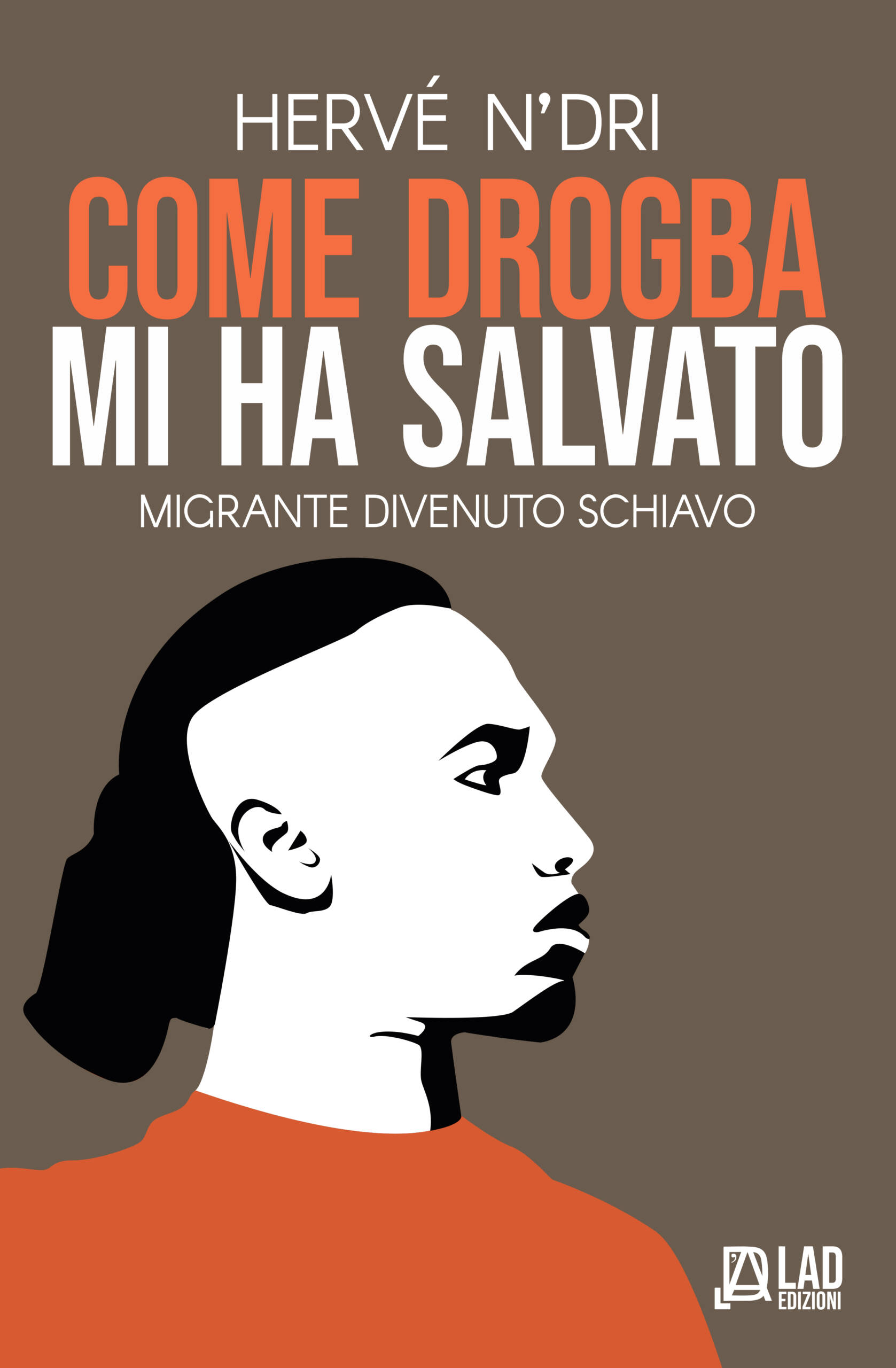Spettri "marxisti" si aggirano nella redazione di Repubblica
di Angela Fais per L'Antidiplomatico
Grazie a un recente articolo di La Repubblica a firma di Enrico Franceschini apprendiamo che Engels avrebbe dato “una visione esagerata” della divisione in classi. In “Situazione della classe operaia in Inghilterra” avrebbe un pò calcato la mano; tipico dei comunisti d’altronde, farla sempre più drammatica di quel che è. A proposito della segregazione tra ricchi e poveri nella Manchester del 1845 secondo uno studio inglese, quell’immancabile e imprescindibile studio inglese, elemento cardine di ogni narrazione dogmatica che si rispetti, Engels si sarebbe preso delle “libertà creative”.
All’università di Cambridge la prof.ssa Emily Chung infatti grazie ad analisi digitalizzate dei dati del censimento del 1851 avrebbe scoperto che molti abitanti della classe media di Manchester vivevano nelle stesse strade e talvolta negli stessi edifici della classe operaia. “Ho scoperto che medici, ingegneri, architetti, insegnanti, bottegai vivevano allo stesso indirizzo di tessitrici e filatrici”, dice la Prof.ssa. E questo sarebbe più che sufficiente a liquidare sbrigativamente Engels, dimostrare che la sua visione è esagerata, forzatamente ideologica. Lo studio non nega del tutto che esista una segregazione di classe, non arrivano a tanto neppure a Cambridge. Ma “è importante -conclude- capire l’esperienza della gente di Manchester che a metà dell’ottocento era una delle prime città industrializzate della Terra”.
Come se ciò rendesse conto della qualità della vita dei “ceti a basso reddito”, che nello studio ci si guarda bene dal chiamare semplicemente “poveri”. Ma cosa è una città industrializzata nel 1800? E cosa significa abitarvi per un operaio? Non possiamo capirlo se ci limitiamo ai dati digitalizzati cui fa riferimento lo studio senza considerare altri fattori cruciali come l’enorme incremento demografico che le città subiscono e la congestione urbana che ne consegue. Nel 1685 Manchester ha 6000 abitanti, nel 1760 tra i 30mila e i 45mila. Tutto ruota intorno alla fabbrica, unico perno dell’organismo urbano. Quando la congestione urbana esplode gli affitti volano alle stelle a causa di una domanda superiore all’offerta che determina una carenza di alloggi. Accade così che anche case dei ceti medi furono fruttuosamente destinate agli operai che vi furono alloggiati trasformando le vecchie case unifamiliari, di certo più confortevoli, in caserme d’affitto.
Persino le cantine all’occorrenza diventano alloggi operai quando non sono adibite a gabinetti. Le analisi digitalizzate di Cambridge tanto apprezzate da Repubblica non rendono conto del fatto che in ogni stanza di queste case era alloggiata un’intera famiglia di operai, parliamo di 15/20 persone per stanza. Ecco spiegato come mai medici e ingegneri vivano nello stesso edificio insieme ai poveri. Ma in condizioni abitative diverse che rendono dunque ancor più stridente il divario di classe. E questo standard durò molto a lungo. In seguito l’abitazione tipo offerta alle classi operaie altro non fu che la standardizzazione di queste condizioni traslate in abitazioni di nuova costruzione alle quali mancava la minima decenza delle case borghesi essendo la loro costruzione pessima sin dalle fondamenta. Così a Manchester, “una delle prime città industrializzate della Terra” -come si legge nello studio- si raggiunge il massimo risultato urbanistico del 1800: viene standardizzato il tugurio industriale. Con buona pace di Repubblica e dei dati digitalizzati di Cambridge nella città industriale, ‘la non-città’ come la chiamano molti urbanisti, i progressi non riguardano le classi lavoratrici ma l’unico obiettivo è il guadagno, il profitto come previsto dalla ideologia che la partorisce.
Se si fa ricerca storica questi non sono particolari che possono rimanere in ombra ma è facile intravedere quale intenzione soggiaccia sia allo studio che all’articolo che lo cita: è l’ossessione che organizza tutto il discorso neoliberista. Si palesa quel che Derrida descrive molto sagacemente in ‘Spettri di Marx’, libro scritto a ridosso della caduta del muro di Berlino. Il comunismo che Derrida definisce “la ferita del capitalismo”, è l’ossessione con cui l’Occidente coltiva un discorso maniacale e osceno che viene replicato all’infinito e col quale scongiura la morte del comunismo tramite un esorcismo che consiste nel ripetere ossessivamente che il mostro è morto.
E’ l’ennesimo tentativo di decostruire i rapporti di forza concepiti attraverso una visione di classe per restituirci il mito della civiltà industriale portatrice di benessere. E’ propaganda e serve a imporre la nuova versione della storia: Engels ha esagerato e ci ha messo molto del suo, anche la Coketown che Charles Dickens descrive in ‘Tempi difficili’ è unicamente frutto della fantasia dello scrittore e la lotta di classe in realtà non ha alcun senso.
“Quando il neoliberismo nonostante tutto non riesce a sbarazzarsi di tutti i fantasmi” -dice Derrida- bisogna ricacciare indietro questi spettri. E’ ancora una volta lo spettro del comunismo che ritorna. Come ritorna prepotentemente ogni rimosso. Perché il muro cade ma gli spettri attraversano i muri, aggirano la coscienza e saltano le generazioni. Allora è necessario ripetere che Marx è morto, che il comunismo è morto, che è finito. E nonostante tutto esso rappresenta ancora la paura più grande. Più viene rimosso più l’Occidente è costretto a esorcismi. Ma il rimosso ritorna sotto forma di ossessione e Derrida chiama “fase giubilatoria del lutto”, un lutto interminabile che l’Occidente non riesce a elaborare. E poiché il fantasma può tornare, si dichiara la morte con “una dichiarazione performativa che rassicuri tutti e che lo renda morto, affinché non torni più”. Quindi si procede come in ogni esorcismo con frasi rituali e dogmatismi autoritari per assicurarsi che “il suo cadavere sia localizzato e imbalsamato come si usa fare a Mosca”. Questa ossessione che è il perno attorno al quale ruota tutto il discorso occidentale costruisce un’ egemonia fragile, continuamente destabilizzata da un’idea, da uno spettro di cui non ci si riesce a sbarazzare nonostante tutto. E così anche in chiusura dell’articolo Franceschini recitando l’incipit del Manifesto: “lo spettro del comunismo si aggira per l’Europa”, poi si affretta a scongiurarlo aggiungendo che “però spesso ricchi e poveri avevano lo stesso indirizzo”. Ignorando clamorosamente la storia delle città industriali e non solo quella, fornisce una versione consolatoria che pacifica quegli animi che hanno bisogno di credere che l’esorcismo sia riuscito.
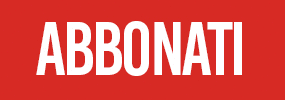

1.gif)